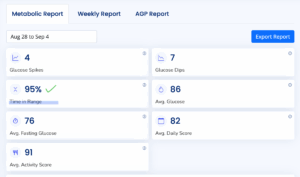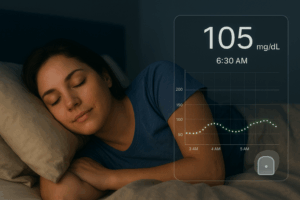La circolazione linfatica è fatta di una fitta rete di vasi in cui scorre la linfa, interconnette gli spazi interstiziali con i linfonodi e gli organi linfoidi (midollo, timo, milza, tonsille, adenoidi) e con la circolazione centrale.
In questo articolo avevo spiegato che cos’è il sistema linfatico e le sue funzioni.
Uno dei suoi ruoli principali è quello di regolare i liquidi extracellulari. I vasi linfatici sono caratterizzati da una sottile parete cellulare (endotelio) a singolo strato, non strettamente serrato proprio per facilitare il passaggio di liquidi, macromolecole (come le proteine) e cellule immunitarie.
I capillari linfatici convergono poi in vasi di maggiori dimensioni dotati di una muscolatura e di capacità contrattile, che a loro volta trasportano la linfa verso la circolazione centrale attraverso il dotto toracico.
In presenza di anomalie del sistema linfatico si presenta una stasi di linfa negli spazi interstiziali (linfedema), accumulo di molecole quali proteine e cellule immunitarie (soprattutto macrofagi), infiammazione e aumento del rischio di infezioni. Il segno clinico più immediato è il gonfiore.
Un’infiammazione cronica può portare ad alterazione della matrice interstiziale con innesco di una fibrosi e ispessimento cutaneo della zona interessata e un aumento del deposito di grasso sottocutaneo e fasciale.
Tale condizione è tuttavia da distinguere da un’altra patologia, il lipedema (vi rimando ad un articolo scritto dalla collega arianna rossoni), con caratteristiche diverse e che necessita di una terapia specifica.
La classificazione del linfedema non è del tutto universalmente condivisa, ma in linea di massima vengono distinte le forme primarie in cui è presente un’anomalia o danno iniziali al sistema linfatico, da forme secondarie ad altri fattori.
Il linfedema primario si distingue in:
– congenito, presente alla nascita
– precoce se si presenta prima dei 35 anni
– tardivo se compare dopo i 35 anni
Sono state identificate anomalie genetiche ereditarie, dominanti e recessive, caratterizzanti stati patologici definiti.
Tuttavia ci sono anche forma in cui è presente una componente genetica ma è necessario un evento scatenante affinché si presenti il linfedema.
Il linfedema secondario si presente in diverse condizioni:
– radiazioni
– infezioni
– tumori
– traumi
– interventi chirurgici in pazienti oncologici (circa il 20-30% dei pazienti dopo un intervento di rimozione del cancro al seno)
– malattie autoimmuni
– obesità
– diabete
Il linfedema primario colpisce prevalentemente le donne (rapporto donne/uomini di 1,5:1 – 10:1).
Il linfedema secondario può colpire entrambi i sessi, generalmente riguarda gli arti superiori o inferiori. Nella maggior parte dei casi è interessato solo un arto anche se si può presentarsi in entrambi.
La diagnosi passa attraverso un esame clinico e una diagnosi differenziale da altre patologie in cui può presentarsi edema (insufficienza cardiaca, renale, epatica e ipoproteinemia).
Il linfedema è caratterizzato da gonfiore, progressiva scomparsa della naturale definizione dell’arto.
La parte gonfia risulta compatta, ne consegue una difficoltà di movimento. La pelle può comparire più spessa e di un colore alterato.
In una fase successiva si può presentare accumulo di tessuto fibrotico e di grasso.
Nell’esame clinico vi è impossibilità di “tendere” la pelle alla base delle dita dell’arto interessato (segno di Stemmer).
Per accertare un sospetto di linfedema, è possibile avvalersi di tecniche di imaging, quali MRI (risonanza magnetica), TC (tomografia computerizzata), linfoscintigrafia ed Eco-Color-Doppler.
La terapia del linfedema è definita terapia complessa decongestiva e comprende due o più dei seguenti trattamenti:
– linfodrenaggio con massaggio manuale
– bendaggio
– presooterapia
– uso di tutori elastici
– intervento chirurgico
I trattamenti farmacologici sono poco utili. L’utilizzo di diuretici altrettanto inefficaci, fatta eccezione in cui siano presente linfedema ed ipertensione.
Lo stile di vita può avere un ruolo importante nel coadiuvare la terapia.
È molto importante mantenersi attivi poiché l’esercizio fisico agisce come “pompa” ed è in grado di migliorare significativamente la circolazione.
L’esercizio fisico non deve essere troppo intenso per evitare la sovra produzione di radicali liberi, che andrebbero a peggiorare l’infiammazione.
È inoltre molto importante facilitare la digestione, evitando apporti elevati di grassi perché porterebbero ad un rallentamento del processo digestivo e appesantirebbero il trasporto linfatico.
I grassi infatti vengono assorbiti dalle cellule intestinali dove vengono “impacchettati” in strutture chiamate chilomicroni e trasportati al fegato attraverso i vasi linfatici.
La dieta deve essere anti infiammatoria.
Cosa significa?
Uno dei punti cardine è la stabilità glicemica e la calma insulinica.
Tradotto in pratica significa eliminare gli zuccheri, le farine raffinate, i farinacei, consumare prodotti animali provenienti da allevamenti NON intensivi, evitare latticini (in particolare quelli di origine vaccina).
È utile ridurre il consumo di frumento (il glutine è una proteina infiammatoria) e abbassare un po’ il consumo abituale di carboidrati (pane, pasta, cereali, patate, etc).
L’equilibrio insulinemico è strettamente collegato all’equilibrio ormonale, per cui vanno evitati tutti gli interferenti endocrini che troviamo nel cibo (pesticidi, erbicidi, soia), nell’acqua e nell’ambiente che ci circonda (plastica, cosmetici, prodotti per la cura della persona e della casa).
È necessario moderare il consumo di sale, scegliendolo integrale, non raffinato (come quello rosa dell’himalaya o il sale grigio celtico). Moderare NON eliminare.
Eliminare invece alimenti conservati, snack, prodotti da forno, salumi.
È più importante eliminare lo zucchero, responsabile di picchi insulinici, infiammazione e ritenzione di sodio e acqua a livello renale.
Una dieta anti infiammatoria si basa su un corretto bilanciamento tra grassi omega 3 (anti infiammatori) e omega 6 (prevalentemente infiammatori).
Quindi ancora una volta vanno evitati tutti i cibi lavorati e processati industrialmente, gli oli vegetali (tranne l’extra vergine di oliva e l’extra vergine di cocco), i prodotti animali di allevamento intensivo (carne e pesce, latticini, uova).
Vanno privilegiati i grassi monoinsaturi (olio evo, avocado, noci di macadamia) e omega 3 (alghe, pesce pescato, carne di allevamento non intensivo o meglio ancora grass fed, uova bio).
Non esagerare con la frutta secca oleosa ed i semi oleosi per il contenuto di fitati, ossalati e per il loro contenuto prevalente di omega 6 (eccezion fatta per le macadamia). Fitati e ossalati potrebbero irritare l’intestino, e favorire l’infiammazione.
Arricchiamo la tavola di verdure di stagione, in particolare le verdure a foglia verde, le crucifere, verdure colorate. La fibra è molto importante per la salute intestinale e del microbioma, in grado di utilizzarla per produrre acidi grassi a corta catena, regola l’assorbimento dei nutrienti e la regolarità intestinale, aumenta il senso di sazietà.
La frutta di stagione è altrettanto indicata, ma attenzione a non esagerare nelle porzioni giornaliere.
Mirtilli, fragole, frutti di bosco, ananas, albicocche, melone, pompelmo, melograno…
Preferire le verdure crude, consumandole almeno una volta al giorno.
Evitare le verdure bollite e i minestroni. Per cuocere le verdure preferire cotture al vapore, in forno o spadellate in modo che perdano acqua.
Il mondo vegetale è un concentrato di micronutrienti, fibre e antiossidanti.
Non dimentichiamo le spezie e gli aromi: curcuma, zenzero, cannella, origano, aglio, salvia, rosmarino, prezzemolo, coriandolo, timo…
È possibile valutare un’integrazione mirata con principi anti infiammatori, anti ossidanti, come la vitamina C ed E, la curcumina, l’acido alfa lipoico, la berberina, il magnesio, gli acidi grassi omega 3, il cardo mariano, alcune vitamine del gruppo B.
Ogni forma di integrazione va personalizzata al singolo caso.